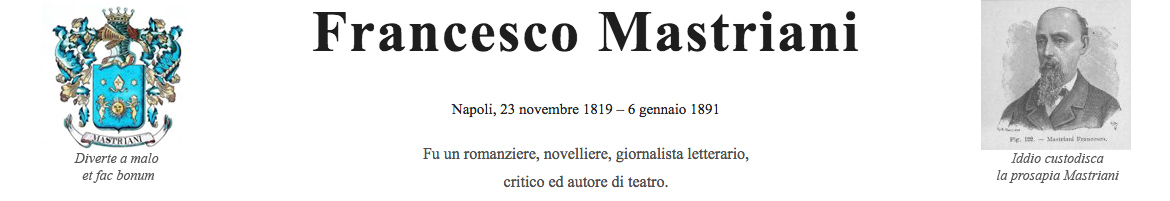Il romanzo «Bernardina» è stato pubblicato per la prima volta in appendice sul quotidiano «Roma» dal 27 febbraio al 25 maggio 1886.
Questo lavoro, non essendo mai stato pubblicato in volume, può essere considerato un inedito, e costituisce il sequel di «Pasquale il calzolaio del Borgo Sant’Antonio Abate».
Come il titolo ci suggerisce, la protagonista è Bernardina, la figlia dello sventurato calzolaio Pasquale.
Il romanzo, in realtà, si apre con il ritrovamento del cadavere di un sergente della gendarmeria all’interno di un sacco – la cui vicenda viene messa temporaneamente a tacere dalle autorità affinché non si sappia chi è il colpevole – e con la presentazione del protagonista maschile, il poeta Eugenio C.
Per mezzo della lettera che il poeta scrive alla sua innamorata nelle prime pagine della narrazione, il lettore riceve diverse informazioni utili a riprendere il filo della storia: Eugenio è innamorato di Bernardina e, pur di sposare la giovane fanciulla, è disposto a chiedere aiuto al ricco zio, il barone Giovan-Giuseppe di C., fedelissimo consigliere del re e garante dell’ ordine monarchico.
Eugenio, invece, sogna un migliore avvenire per il proprio Paese e l’avvento della repubblica; nella lettera, infatti, si legge: «Oh come vorrei non portare un cognome che fa montare il rossore su la mia fronte!».[1] Il poeta, dunque, si vergogna di appartenere ad una famiglia fedele al re Ferdinando e, non a caso, firma i suoi articoli e le proprie carte con il cognome fittizio Leoni.
Il protagonista è un ribelle, un nemico della corona e questa sembra un’ottima motivazione per arrestare il giovane e farlo rinchiudere nelle carceri della città. È il 1846.
L’autore non manca di riportare alla mente del lettore i fatti
narrati nel precedente romanzo, in particolare, quelli legati alla catastrofe del 24 giugno 1831, quando il calzolaio Pasquale uccide Claudina la Sicilianella mentre quest’ultima, dopo aver ucciso la moglie del calzolaio, tentava di strangolare la piccola Bernardina. La mente del povero Pasquale non riesce a sopportare né il rimorso per essersi reso complice del delitto compiuto ai danni della moglie né il dolore provato alla vista della propria figlia strangolata da quella donna. E così, mentre l’uomo viene condotto prima nelle carceri-ospedale di San Francesco e poi nel manicomio di Miano, la povera Bernardina rimane orfana di entrambi i genitori.
La bambina viene affidata alle cure dell’operaio calzolaio Gasparino d’Aniello e della moglie Lauretta, che nutrono un affetto sincero nei confronti della povera orfanella e decidono di istruirla presso il Conservatorio della Immacolata Concezione.
Qui, una ancora giovane e innocente Bernardina conosce Faustina, una ragazza libertina che ha le idee molto chiare sul proprio futuro, come si apprende dalle sue parole: «Le brutte si mettono al lavoro: le stupide si chiudono in un ritiro per morirvi tisiche: ma le belle, se abbiano un poco di spirito, o si maritano bene, o trovano qualche messere che lor procacci una vita comoda e senza darsi la più lieve fatica.».[2]
Questi discorsi, uniti alla lettura di alcuni romanzi licenziosi e all’influenza della madre di Faustina, la marchesa Amalia Prèval, inaridiranno e travieranno inevitabilmente l’animo dell’ ingenua Bernardina.
In questo contesto, l’autore non manca di inserire una nostalgica digressione circa la bellezza della sua Napoli, una capitale incantevole in quel lontano 1844, quando la nobiltà sapea divertirsi, nelle sale da ballo del club di San Giorgio a Cremano, nelle serate trascorse al teatro San Carlo o nelle passeggiate domenicali per la via Toledo, tutte occasioni in cui le dame facevano a gara per sfoggiare i loro abiti eleganti e i
loro gioielli.
In effetti, non è difficile riscontrare nel testo molti riferimenti sulla moda femminile del tempo, che segue le tendenze dello stile parigino: «Era un mantello di cascemiro, colore cenere d’Egitto, ossia grigio un po’rossiccio, il quale avea la gonna molto ampia, il collare grande e splendidamente ricamato, con grosso fermaglio.». [3]
Come avrebbe potuto il povero Eugenio competere con quella realtà così sfarzosa e folgorante? Che ascendente poteva avere lui, che andava in giro vestito alla carlona come un vecchio notaio o come un usciere di tribunale [4], sull’ormai disinibita Bernardina?
Mastriani risponde magistralmente a queste domande tramite i versi del Tasso nella «Gerusalemme Liberata»:
“Ei che modesto è si com ‘essa è bella.
Brama assai, poco spera e nulla chiede.
Né sa scoprirsi, o non ardisce, ed ella
O lo sprezza, o nol vede,
o non s’avvede.”[5]
E così, traviata nell’animo dalle promesse dell’amica Faustina, la povera Bernardina è costretta a rinunciare al suo onore e cadere nelle grinfie del perverso barone Giovan-Giuseppe pur di vivere quella vita agiata che tanto aveva sognato.
In questa parte del romanzo, la narrazione si arricchisce di elementi emozionanti e le pagine sembrano essere avvolte da un alone di mistero, come se da un momento all’altro dovesse accadere qualcosa di terribile: «Veramente, quella mattina la figliuola di Pasquale si era levata con una grande malinconia sul cuore, della quale ella stessa non avrebbe potuto addurre una ragione qualunque. Era forse uno di quei vaghi presentimenti che rattristano l’animo per vicina ignota sventura?» [6].
E l’attento lettore forse ricorderà che quella stessa malinconia l’aveva provata la madre di Bernardina il giorno in cui venne uccisa dalla Sicilianella, come se quel sentimento fosse presagio di sventure.
Gli stessi sentimenti campeggiavano nel cuore di Eugenio. che così scriveva alla sua amata poco prima di essere arrestato:
«Diletta del mio cuore – egli scriveva all’angelo dei suoi pensieri – ho l’anima trista come per morte, come disse nostro Signore Gesù Cristo nell’orto di Getsemani.».[7]
Non per ragioni politiche, dunque, ma per gelosia che il giovane poeta verrà arrestato. Eliminato questo ostacolo, nessuno potrà fermare il barone che, con un deplorevole inganno, renderà l’ingenua Bernardina sua amante e concubina.
Sempre viva, poi, l’attenzione dell’autore per le classi meno abbienti che, in questo contesto, non manca di inserire indirettamente una critica nei confronti di una società corrotta dal Dio denaro: «Scostatevi, scostatevi, miserabili pezzenti, vermi della terra, infelici che lavorate per vivere, lasciate passare i nostri sbuffanti corsieri, le nostre giumente puro sangue, che tra poco otterranno il premio promesso alla vittoria. Se non volete essere schiacciati dalle nostre bighe fulminanti, aggruppatevi in due file su i marciapiedi, ed ammirate la nostra grandezza, la nostra magnificenza! Dall’altezza de’nostri stage-coaches noi gittiamo uno sguardo di commiserazione su coteste migliaia di teste pallide e grame che si levano stupefatte a guardarci: e deridiamo alla loro miseria, e, più che alla loro miseria, deridiamo alla loro ignava e stolida codardia ed alla loro somaresca pazienza. Il prete vi dice dal pulpito Beati i poveri! Ma per ora, siamo noi i beati, e voi i gonzi!».[8]
Non a caso, Mastriani costruisce un finale denso di colpi di scena che, ancora una volta, incoraggia il lettore alla riflessione: Pasquale Morfi, rinsavito e rimesso in libertà, impazzisce nuovamente e muore poco dopo aver scoperto che
la sua cara figlioletta ha perso onore e dignità diventando la concubina di un perverso barone; quest’ultimo, costretto a scappare da Napoli dopo aver perso l’appoggio del re, muore tragicamente a Trieste dopo aver ingerito delle droghe che avrebbero dovuto rinvigorirlo in una notte d’amore con una danzatrice tedesca. La stessa sorte toccherà infine a Bernardina, che morirà felice dopo aver salvato la vita al suo Eugenio, rilasciato grazie alle nuove idee costituzionali instaurate nel regno e arricchito dopo il testamento dello zio barone che lo nomina suo unico erede.
Eugenio, l’eroe del romanzo, colui che fin dall’inizio porta in dote nient’altro che onestà e virtù, alla fine viene baciato dalla fortuna, pur rimanendo un uomo di valore e sentendosi quasi a disagio nei panni dell’abbiente: «Questa volta la eredità, questa figlia dell’avarizia e madre di tutti e sette peccati mortali, ne avea finalmente imbroccala una! Aveva arricchito un giovine di mente e di cuore; avea fatto, senza intenzione, una opera buona. […] Ma il nostro Eugenio non era plasmato per la ricchezza, per la quale si richiede una ossificazione particolare.» [9].
L’ultima parte del romanzo è intrisa di storia con il lungo racconto delle barricate del 15 maggio 1848, giorno in cui la città è magistralmente paragonata a una pagina dello Shakespeare o a un quadro del Van Dick.
Ancora una volta, dunque, la storia fa non solo da sfondo alla narrazione, ma diventa protagonista indiscussa del romanzo grazie agli innumerevoli riferimenti ai personaggi del tempo, ai puntuali commenti sul re Ferdinando e la sua Corte e alla minuziosa descrizione degli eventi che culmineranno nel 1860, quando Eugenio, dopo essere scappato per sfuggire alla reazione borbonica, tornerà a Napoli a fianco del generale Garibaldi.
ELVIRA TROVATO [10]
[1] F. MASTRIANI, Bernardina, in «Roma», 1886.
[2] Ivi, in «Roma». 1886.
[3] Ivi, in «Roma», 1886.
[4] Ivi, in «Roma», 1886.
[5] Ivi, in «Roma». 1886.
[6] Ivi, in «Roma». 1886.
[7] Ivi, «Roma», 1886.
[7] Ivi, «Roma», 1886.
[9] Ivi, «Roma», 1886.
[10] Docente di lettere. Da sempre appassionata di romanzi d’appendice, si è laureata in Filologia Moderna presso l’Università degli Studi di Catania, con una tesi su due lavori letterari di Francesco Mastriani: «Due feste al Mercato» e «Il campanello dei Luizzi».