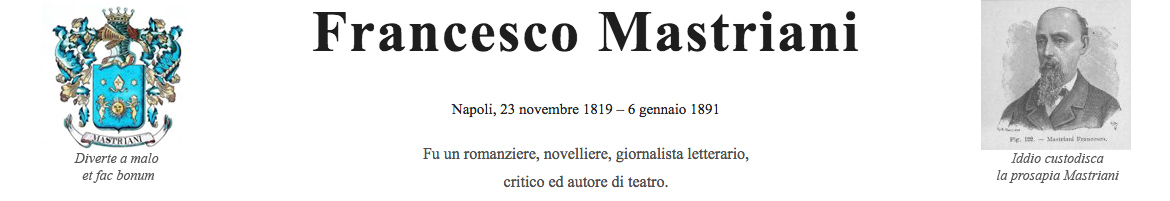L’Autore Drammatico presso di noi non è una professione come l’Attore; lo scarso guadagno che si ricava da’lavori teatrali, le contrarietà innumerevoli, cui si va incontro nel porre sulle scene un’opera qualunque, il gusto del pubblico sempre incerto e variante, e le stesse non poche difficoltà dell’arte e della lingua scuorano ed allontanano i buoni ingegni della penisola a darsi esclusivamente a questa branca della letteratura, che con tanto favore è accolta e compensata in Francia ed altrove.
Ed in vero quando la letteratura non è di per sé stessa in Italia una professione, come potrebbesi mai pretendere che la fosse una branca, che richiede la scienza delle lettere, l’acume del filosofo, e l’anima dell’artista? Se in Italia si trovasse chi si desse a tutt’uomo, e con successo a scriver drammi e commedie senz’altro mezzo di sostentamento, che quel misero lucro del teatro, quest’uomo sarebbe senza dubbio un eroe, un martire dell’arte.
Presso di noi di presente l’Autor Drammatico non è altro che un giovine che ha scritto qualche mediocre articolo di giornale, parecchie romanze per musica, ed un’ode lunga lunga a qualche cantante; sovente questo giovine è un commesso di casa commerciale, un legista o un medico in erba, e spesso ancora un esclusivo cioè un perdigiorno infarinato nella letteratura de’salons.
Ecco il modo come da alcuni si compone un dramma.
Ad un giovine di quelli testé cennati, con molti peli al mento e sulle labbra, con le vaghe zazzere arricciate dal Paolucci, con un soprabito tagliato all’ultima figurina del Sibilo, viene in testa il capriccio della gloria come forse pocanzi gli era venuto il capriccio di fumarsi un sigaro d’Avana: non contento di veder stampato il proprio nome sotto una colonna di giornale moribondo sovra un deschetto in un Caffè, vuol vederlo (il suo nome) stampato a grandi lettere sovra gli affissi teatrali; ed ecco che si ritira in casa, apre un romanzo francese, ne cambia il titolo ed i nomi de’personaggi, copia le scene e i dialoghi, schicchera dodici fogli di carta, e manda giù un dramma per concorso.
Un altro sente un peso sullo stomaco, una noia, un’ipocondria come lo spleen; non sa a che attribuire questa infermità; alcuni gli han detto che lo studio il facea tristo, e che però pensasse soltanto a divertirsi; altri pretendono che egli, roso dal suo genio, dovrebbe, anzi che cercar di vincere la sua noia, coltivarla come lo scatto più potente ad opere immortali; quest’ultima opinione lo persuade; il nostro novello Jacopo Ortis fugge gli uomini e il Caffè d’Europa, si chiude come un lupo nella sua tana, legge una pagina di Souliè o di Sue, e si mette a scrivere… che cosa? Un dramma nero nero, il cui protagonista è un essere mezz’uomo e mezzo belva; divide il lavoro in otto quadri, ognuno de’quali finisce con un punto di scena terribile, feroce, sanguinoso.
Fra sei giorni e sei notti ha terminato il suo dramma (egli ha lavorato nelle tenebre come Sofocle).
Al settimo giorno l’Autor Drammatico spicca una circolare a’suoi amici per farli venire in sua casa ad ammirare il suo genio: la sera si aduna eletta mano di giovani drammatici tutti profumati, tutti galanti, tutti mostri d’ingegno; seggono in cerchio intorno al neofita del teatro, il quale con maestosa ed altisonante voce declama il parto robusto della sua drammatica mente. Ad ogni scena è un grido di maraviglia, un plauso di ammirazione; si contano sulle dita i morti e i fracassati; si estolle al cielo la caduta di un uomo col capo in giù; e si grida al portento quando alla fine del dramma comparisce il protagonista col ventre aperto, o viene a mostrare al pubblico stupefatto e rapito i visceri palpitanti nell’agonia di morte come una vittima inghirlandata immolata a’numi del Paganesimo.
È risoluto però che il dramma farà furore: l’Autore si affretta di mandarlo al teatro; l’aspettativa del trionfo gli toglie il sonno; nel suo capo si aggirano tanti rosei pensieri! In quella sera egli darà un palco alla sua innamorata affinché il vegga comparir chiamato sul proscenio in mezzo agli attori redivivi che lo abbracciano e lo salutano primo scrittor drammatico dell’Italia! Eccolo oramai balzato sulla ruota letteraria a livello di Hugo; eccolo famoso; pochi altri giorni, ed oh sovrano de’ piaceri! il suo nome che prima non si leggeva che su qualche libro di sarto o di mercante, o sovra i bigliettini di visita, si vedrà ora scritto su i cartelli del teatro, in tutte le strade maestre della città, e poscia si leggerà in tutt’i giornali, ed in tutte le opere periodiche. Non più noia, non più tristezza, egli è il più felice de’viventi.
All’Autor Drammatico è affidata la sacra missione di correggere i costumi e la morale d’un paese, di mettere a giorno e in ridicolo le più spiccanti caricature; ma egli deve ciò dare indorando l’amara pillola con i sali e le veneri del dialogo, con l’interesse d’una azione sostenuta e verosimile. Se, parlando degli Attori dicemmo che costoro dovrebbero essere considerati come altrettanti pubblici oratori, diremo degli Autori che questi, allorché ottengono il nobile scopo cui mirano, debbonsi a giusto titolo addimandare altrettanti legislatori di pubblica morale.
Per esser buon autore ei da d’uopo essere altresì attore, o almeno sentire al vivo le passioni che voglionsi ritrarre: i migliori drammaturgi hanno calcato le scene. Lo scrivere pel teatro richiede la fantasia viva e calda, il cuore bollente, e lo spirito colto. Un dramma o una commedia non sono lavori freddi che un letterato può scrivere senza sentirsi antecedentemente accendere il capo, e tremar le fibre come avviene all’attore nel punto di uscir sul proscenio.
Si è declamato molto contro l’uso vigente in Francia di scrivere drammi e commedie in società: si è detto che questo dovea per necessità tradire i caratteri, complicare l’azione, e snervare il dialogo. Io credo esser falsa l’opinione di costoro che declamano contro quest’uso, e dico solamente (non per imitar Cicero pro domo sua) che un lavoro teatrale sendo ardua e difficile impresa per giovani esordienti che voglionsi arrischiare nell’arringo drammatico, non è male che si mettano quattr’occhi invece che due, e due polsi invece d’uno. Un subbietto non può forse apprendersi da due nello stesso modo? Un personaggio non può forse identicamente foggiarsi da due? E il dialogo non vuol forse dire un discorso tra due persone?
FRANCESCO MASTRIANI