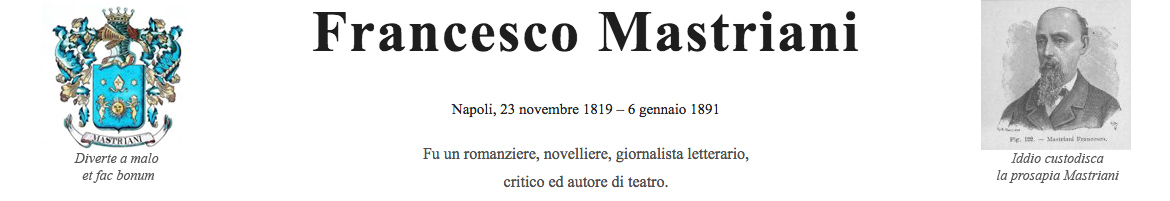Cenere o La sepolta viva (1877)
Non si può fare a meno di notare che, come tecnica narrativa, nella impostazione generale, Cenere, è un romanzo molto vicino a Eufemia. In entrambi i casi il narratore, lo scrittore stesso, diventa personaggio e raccoglie dalla viva voce dei protagonisti la testimonianza che costituisce il romanzo [1]. Come form of fiction troviamo dunque l’ovvia, forte presenza della confession. Il che corrisponde a un’aggiunta di realismo alle alterazioni mentali della protagonista causate dai maltrattamenti dei parenti:
Mi abbandonai sul mio letticciuolo, risoluta a non prendere più nutrimento di sorte veruna per lasciarmi morire d’inedia. Aspettavo la morte. Non so quanto io rimasi in una perfetta inerzia corporale e sotto i mille spettri creati dalla immaginazione sovreccitata dall’esalamento del mio sistema nervoso [ …] Il mio covile si popolò di orridi mostri dalle strane forme, di cui ciascuno era, per così dire, lo esecutore d’un supplizio diverso. Ma tutti questi mostri aveano più o meno le sembianze di Teresa, di Alfonsina, di Padre Anselmo. E gli uni mi abbruciavano le carni con tizzi ardenti; gli altri mi fendevano il seno con unghie adunche; alcuni stretti alla mia bocca mi succhiavano il sangue; altri mi colpivano il capo con fieri colpi di mazza [2].
Simile realismo gotico ritroviamo nelle raccapriccianti scene di orrore cimiteriale in cui la protagonista si sveglia nella camera mortuaria e tenta la fuga vagando fra le tombe:
Battevo i denti pel freddo… La fiacchezza delle gambe era estrema […] Non ero più che uno spirito, il quale avea rapito alla tomba la carne di che era testé rivestito e trafugavala con esse lui. Agli occhi stessi miei ero un fenomeno soprannaturale, una meraviglia, una novità. Mi pareva che il vento mi dovesse rapire alla terra. Mi sembrava che i defunti levassero il capo dagli scoperchiati loro monumenti per sospetto che la tromba finale del Giudizio fosse sonata. Le ali di tristi augelli mi battevano sul viso. Il rumore del vento tra quei lunghi viali mi risuonava all’orecchio come strilli delle anime del Purgatorio. Le mie scarpine (elegante calzatura del sepolcro) affondavano nella umida terra; ed a me parea che i morti mi afferrassero pei piedi e volessero per forza ritenermi con loro [3].
Per meglio intendere, anche in questo caso, mi pare opportuno “raccontare”. I fatti narrati hanno inizio una sera del 1861. L’autore, Mastriani personaggio, incontra una giovane donna che appare disperata. La soccorre, ma lei scappa subito via. Attraverso varie ricerche il narratore arriva a scoprire qualcosa della giovane. Egli poi la incontra in compagnia di un “americano” di Costa Rica, in un albergo di Capri, dove il narratore è andato per trascorrere un breve soggiorno col suo parente ed amico Francesco Galluppi (fatto confermato dalla biografia di Filippo Mastriani). La giovane donna conosce le opere del romanziere e questo le da fiducia, parla con lui e gli racconta la sua storia. Figlia di Epifanio K. (“lettera dell’alfabeto greco” dietro cui si cela di nome di una nota famiglia napoletana) e della seconda sua moglie Elisa (morti entrambi prematuramente), dice che sebbene il suo nome sia Eva ora si chiama Ceniza, e che ha subito i più cattivi e violenti maltrattamenti in famiglia da parte del fratello e della sorella. “Ceniza” è “Cenere” in spagnaolo. Cenere, come il fratello e le sorelle l’hanno chiamata per disprezzo e per augurarle la prossima morte, racconta di come sia stata rinchiusa come una sepolta viva per vari anni, in uno sgabuzzino adiacente al terrazzo del palazzo in cui abitava la famiglia. Lì, in quell’angusto luogo, aveva fatto conoscenza fortunosamente con la vicina di casa Filomena Esposito, poverissima, sola e malata di tisi. Filomena le era stata di grande conforto e, prima di morire di tisi, le aveva lasciato la chiave dello sgabuzzino-prigione che, per felice coincidenza, corrispondeva alla chiave della sua propria abitazione nel sottotetto. Eva/Cenere usciva sul terrazzo la notte.
Vide in una delle sue uscite notturne, e poi amò, Isidoro Baldini, pittore lombardo. I due vissero intensamente il loro amore. Eva/Cenere, incinta, venne poi abbandonata da Isidoro che poco dopo si tolse la vita. Le crudelissime sorelle infierirono ulteriormente sulla disgraziata. Le percosse la fecero abortire. Eva/Cenere, perse l’uso della voce; tentò la fuga con l’intenzione di darsi la morte, ma soccorsa dal narratore rientrò a casa. Ulteriori percosse portarono la donna a uno debilitazione tale che le procurarono la morte apparente.
Si svegliò nel cimitero, su un tavolo di marmo. Per fortuna non era stata ancora sepolta. Si alzò, usci dal cimitero, vagò nella notte e finì in un commissariato di polizia. Venne visitata da un medico che, trovatala non vergine, indicò la via della prostituzione. Eva/Cenere venne reclutata da una “madame”. Iniziò così la sua vita di prostituta. La chiamavano “la Muta”. Per la bellezza acquistò una sua reputazione. Venne raccomandata da un amico al ricchissimo “americano” Giorgio Parral Y Prado. Questi se ne innamorò a prima vista: era proprio lei la sua donna ideale. La “riscattò” e la portò con sé. A Milano un bravo medico restituì la voce alla donna. I due, poi, girarono il mondo e, a Capri. incontrarono Francesco Mastriani.[4]
FRANCESCO GUARDIANI
[1] Sul “cosiddetto personaggio Mastriani” vd. Emilio e Rosario Mastriani (EMILIO MASTRIANI, ROSARIO MASTRIANI, Le prefazioni di Mastriani quali luoghi, in ADDESSO-EMILIO MASTRIANI-ROSARIO MASTRIANI, Che somma sventura è nascere a Napoli!, cit., p. 68) che riflettono sull’importanza del tema indicato da Antonio Palermo (ANTONIO PALERMO, Da Mastriani Viviani. Per una storia della letteratura a Napoli fra Otto e Novecento, Napoli, Liguori, 1987, pp. 119 sgg).
[2] FRANCESCO MASTRIANI, Cenere o La sepolta viva, Napoli, Ginka, 1875, p. 155.
[3] Ivi, p. 177.
Colgo l’occasione per notare una variante di qualche peso, credo, per una futura edizione del romanzo. Lo leggo in due edizioni diverse, in Roma, Perino, 1889 e in Napoli, Ginka, 1975. La prima edizione, sul Roma è del 1877. Nella “Conclusione” della Perino 1889 trovo,: «In quell’anno 1868 io aveva ancora il mio dilettissimo Edmondo, rapitomi nel novembre 1875 da lunga e penosa malattia. – Povero angelo martire. Eravamo giunti al primo novembre. La sera precedente Eva mi aveva pregato di entrare da lei la mattina appresso. Non mancai». (pp. 161-162). In Ginka 1975 invece: «In quell’anno 1868 io aveva ancora il mio dilettissimo Edmondo, rapitomi nel novembre 1875 da lunga e penosa malattia, e la mia carissima Sofia, che si partiva di questo mondo la sera del 5 novembre 1878, e la cui perdita amarissima ha lasciato nel mio cuore una tristezza invincibile. – Poveri angeli martiri. Eravamo giunti al primo novembre. La sera precedente Eva mi aveva pregato di entrare da lei la mattina appresso. Non manca» (p. 194). È solo una piccola tessera, ma attesta il coinvolgimento veristico di Mastriani in questa come in altre opere.
⁂⁂⁂
Il romanzo sarebbe nato da un manoscritto avuto dalla protagonista. Secondo la studiosa Cristiana Anna Addesso, si tratta invece di una tecnica narrativa, il voler far credere che la trama del romanzo sia nata da una vicenda realmente accaduta. Oltre a questo romanzo e a quello citato da Guardiani nel suo commento, «Eufemia», ci sono altri lavori dello scrittore dove usa questa tecnica descrittiva; «Le memorie di una monaca», «Karì-Tismè. Memorie di una schiava», «Angiolina o La corifea», «Giovanni Blondini. Memorie di un artista».
In questo romanzo ci troviamo diverse notizie biografiche dell’autore. Apprendiamo che il suo numero preferito è l’8: Dico in parentesi che questo numero 8 mi è stato sempre simpatico: è il mio numero preferito. [1]
Diverse le digressioni nel corso del romanzo. Sulla compagnia di libri noiosi scrive che durante la traversata per recarsi in gita a Capri, prevedendo la lunghezza del viaggio, prima d’imbarcarsi in una di quelle barcacce a vela che fanno il cabotaggio dell’isola due o tre volte al mese [2], comprò un libro dal quale mi ripromettevo una certa piacevole istruzione, ma non arrivai a leggerne una ventina di pagine… quel libro aveva il più grave difetto che possa avere un libro: era noioso, difetto che non ho saputo perdonare né al gran Petrarca…. nè al gran maestro Verdi, le cui ultime musiche…. mi fanno scientificamente addormentare[3].
Non è la prima volta, nei suoi romanzi, ma anche nelle recensioni teatrali su giornali, che l’autore è molto critico sulla musica di Giuseppe Verdi. Ancora in questo romanzo ci troviamo scritto: In quanto a me, preferisco due note della «Norma» o della «Lucia» a tutto lo spartito dell’«Aida» o della «Forza del Destino» [4].
E sulla rivoltella: Ma qui voglio fare una leggera digressione. Vorrei domandare al nostro governo italiano perché conceda così facilmente il permesso di portare addosso la più scellerata delle armi inventate dalla odierna civiltà qual si è la rivoltella o il revolver, mentre ei dà l’ostracismo all’arma del gentiluomo qual si è la spada o lo stocco…La rivoltella è arma omicida di offesa e non di difesa: è arma da brigante, da camorrista, da facinoroso, le leggi del duello la escludono dalle armi cavalleresche, perché dunque il governo concede il revolver e proibisce lo stocco? È questa una delle tante incongruità della sapienza de’grandi uomini che furono messi al governo della nostra Italia.[5]
La trama del racconto si svolge nell’anno 1861, cioè agli albori dell’Unità d’Italia, per cui vengono menzionati sia personaggi presenti a Napoli nel periodo antecedente, e cioè i Borboni, che relativi al novello ordine politico della nazione unificata. Correvano tempi sospetti. Era il 1861, e le passioni politiche fervevano ancora. Le famiglie che erano state danneggiate dalla caduta de’Borboni, non poteano amare il novello ordine di cose e vivevano ritirate, uggiose, cospirando in cuor loro e facendo voti pel ritorno del “figliuolo della santa”, com’essi chiamavano il re Francesco.[6]
Una sera, l’anno passato, il giorno di Piedigrotta, l’8 settembre, il giorno appresso alla venuta di Garibaldi in Napoli, quando ci erano tutti quei rumori a Toledo[7].
Tra i personaggi del romanzo, figura il pittore lombardo Isidoro Baldini, che l’autore considera un libero pensatore, tendente all’ateismo; tra i libri preferiti di questo artista c’è il «Dizionario filosofico» di Voltaire e quasi tutte le opere del Rousseau. Da convinto credente, Mastriani non poteva fare a meno di criticare la filosofia adottata dal pittore lombardo, che conclude la sua esistenza col suicidio, e decisamente contrario al suicidio, l’autore scrive: Ah! se il misero giovane avesse riletto l’aurea pagina della «Nuova Eloisa» di questo filosofo ginevrino, nella quale con tanta eloquenza condanna il suicidio! Forse il Baldini avrebbe abbandonato il funesto consiglio di darsi la morte.[8]
Parte del romanzo si svolge nell’isola di Capri, dove l’autore si era recato per fare degli studi su Tiberio, in quanto sua intenzione era di scrivere un romanzo storico su questo personaggio, e dove incontra, in maniera incredibile Eva, la protagonista del racconto. Ricorda che Ulisse in quest’isola vi deificò un palagio, che si perdé forse nelle nuvole; ed anche: agli Argonauti che su questa isola riposarono dalla loro spedizione del vello d’oro; e ancora: pensai a Crispina e Lucilla, moglie e sorella dell’imperatore romano Commodo le quali furono quivi relegate.[9]
Francesco Mastriani nel suo soggiorno a Capri prese alloggio all’Hotel Tiberio, uno dei migliori alberghi dell’isola, e che ha dinanzi a sé la bella prospettiva del Golfo di Napoli, colla costiera amalfitana a dritta, colla antica Pitecusa a sinistra e con Partenope in lontananza.[10] Pitecusa è l’antico nome dell’isola Ischia (Pithecusae, Pithekoussai in greco).
La protagonista della storia, Eva o Ceniza, pur essendo vissuta in seguito lontana dalla sua città natia Napoli, non perse una dolce abitudine, propria dei suoi concittadini, il sonnellino estivo pomeridiano, la controra: soggiungendo che sarebbesi rifatta del sonno in quelle ore del pomeriggio che in Napoli diciamo la contr’ora.[11]
ROSARIO MASTRIANI
[1] Francesco Mastriani, La Sepolta viva, Napoli, Bideri 1949, pag.53
[2] Ibidem. pag.42
[3] Ibidem, pag.43
[4] Ibidem, pag.43
[5] Ibidem, pag.185
[6] Ibidem. pag.12
[7] Ibidem. pag.12
[8] Ibidem. pag.30
[9] Ibidem. pag.52
[10] Ibidem. pag.43
[11] Ibidem. pag.140