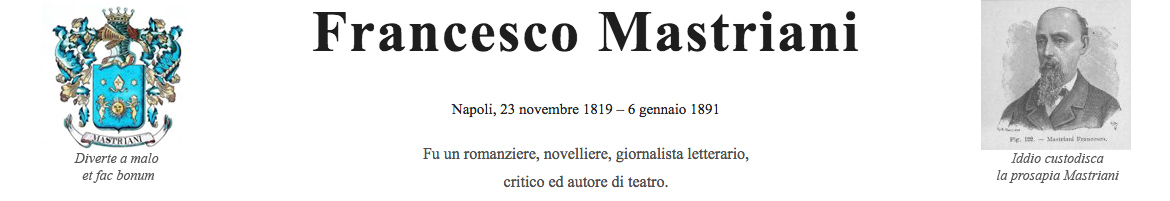I drammi di Napoli sono in effetti due: quello che ha al centro il conte Ciriaco, il “lussurioso”, e quello che vede protagonista Mezzocannone, il “mostro”. È uno dei romanzi più importanti di Mastriani per quanto riguarda la sua fede scientifica, o meglio il suo sperare che la nuova scienza antropologica, ovvero la frenologia, possa portare ad un miglioramento del genere umano e delle sue condizioni di vita.
I drammi sono due studi sul cosiddetto “Fatum organico”, che costituisce il carattere della persona determinato dalla conformazione delle ossa del cranio. La forza del fatum del conte Ciriaco si rivela nel suo sofferto tradimento della famiglia per stare insieme a Valentina, l’affascinante indipendente e ambiziosa giovane che sconvolge i sentimenti dei suoi ammiratori.
Il caso di Mezzocannone è diverso e, per quanto possibile, più drammatico. Mezzocannone è un “mostro”, appartenente a una classe antropologica di nuovo conio nella carriera letteraria di Mastriani, siamo nel 1878 (salvo errore). Una classe che si va a sommare a quelle dei “vermi” e delle “ombre” degli anni precedenti. Si ritrovano dunque in questo romanzo, come nella cosiddetta triade socialista, la preoccupazione del Mastriani per i fatti sociali e la volontà di cercare con nuovi mezzi intellettuali delle verità fondamentali della psicologia, individuale e collettiva, che possono aiutare a capire e migliorare la vita.
Le pagine “frenologiche” di questo romanzo sono molto numerose e molto precise. Si conferma quindi l’esigenza critica di ricercare le fonti di questo attivissimo scrittore. Come primo punto di riferimento ci sono gli scritti del fratello, Giuseppe Mastriani. Da ricordare che nei Misteri, l’autore fa un diretto riferimento elogiativo dell’opera del fratello.
FRANCESCO GUARDIANI
⁂⁂⁂
Nella prefazione del romanzo, l’autore esterna tutta la sua delusione per il fatto che il realismo sia stato attribuito a Zola: «Come si può avere il coraggio di dire che il Zola è stato il primo a creare la scuola del realismo nel romanzo, quando io, Francesco Mastriani apersi nel romanzo questa arditissima scuola co’miei Vermi, colle mie Ombre, co’miei Misteri di Napoli?»[1]
È critico anche nei confronti di Petruccelli della Gattina «che chiama platitudes i miei romanzi»,[2] e del De Sanctis il quale afferma che «Dalbono è il più napolitano tra gli scrittori Napolitani, dopo che il Mastriani ha scritto finora CINQUANTA romanzi, tutti intesi a svolgere le virtù ed i vizi, l’indole e i costumi del popolo di Napoli»,[3] e di un giornale di Napoli (che non ne indica il nome) il quale «con ispudoratezza senza pari togliesse il mio nome tra i novellieri moderni.»[4]
Questa presa di posizione sulla paternità del realismo, la troviamo in un altro suo lavoro « Che che ne dica qualche nostro criticuzzo infraciosato, nessuno può contrastarmi la priorità in Italia di quel genere che oggidì si domanda verismo» [5].
Nel titolo completo del romanzo c’è il lemma Fatum, il destino, che però «non è quello degli antichi greci o romani, deità inflessibile che teneva asservati la suo dispotico volere uomini e cose; e né tampoco è il Destino de’Turchi che non si scommodano per evitare un pericolo, asserendo che, se è scritto, morranno, e, se no, camperanno»[6]; ma per Mastriani «Il Fatum, di cui noi intendiamo parlare, e che pure è despota prepotente del povero seme di Adamo, è quella irresistiblie propensione che ogni uomo porta seco, nella propria conformazione, a questa passione o a quella, a questo vizio od a quello, come pure a questa od a quella maravigliosa attitudine alle opere dello ingegno o del genio.»[7]
In definitiva per Mastriani sia i drammi della umana vita, che la gloria e i grandi successi «tutto ciò dipende dalla particolare conformazione del nostro organismo»[8], e specifica che «Tutte le deviazioni del tipo umano costituiscono più o meno, per così dire, la patologia dell’anima. Ogni deviazione speciale costituisce un vizio, un fato organico.»[9]
Nella parte seconda del romanzo I Mostri, la descrizione del fatum è più dettagliata «Il tristo gioco delle passioni è l’effetto della particolare conformaziine ossea. Nel nostro scheletro sta il genio o il delitto, la virtù o il vizio… questo carattere esoso dell’umano sembiante dovrebbe formare una grande attenuante ne’giudizi criminali»[10]
Il titolo del romanzo è completato con la dicitura di «Romanzo Storico» ma in verità di eventi storici ne troviamo pochi. Viene citato spesso Ferdinando II che fu il penultimo re di Napoli, regnò dal 1830 alla sua morte nel 1859, e la trama del romanzo si svolge in prevalenza nel 1838. Viene citato il terribile capo della polizia «S. E. il Maresciallo di Campo, Francesco Saverio Delcarretto, nome che fa ancora tingere di pallore le facce dei napolitani…[11] comunque ministro di polizia Delcarretto non era tetragono alle grazie del sesso gentile[12]…Nel 1839 Delcarretto non era vecchio, ed era un bell’uomo, per quanto possa essere bello un ministro di polizia». [13]
Tra i personaggi del romanzo, c’è un altro corso, un giovane che si fa chiamare Napoleone Frejus, ma il suo vero cognome è Barberà «ed era figlio del famoso Corso Giacomo Barberà che, venduto a’Borboni di Napoli, tradì Gioacchino Murat nella costui spedizione per riconquistare il regno di Napoli»[14] e sempre in questo capitolo viene descritto questo tentativo del Murat iniziato il 28 settembre 1815, quando salpò dalla Corsica con solo sette navi, in una delle quali era appunto il Barberà, che tradì il Murat che fu catturato e moschettato a Pizzo il 23 ottobre 1815 «Giacomo Barberà fedifrago venne nelle grazie de’Borboni….suo figlio sotto lo pseudonimo di Napoleone Frejus, e fu spia di Ferdinando II, che lo avea creato commendatore»[15]
Varie le digressioni in questo romanzo.
Il conte Ciriaco, una volta ottenuto il possesso della moglie col matrimonio, cerca in altre donne quella attrattive che in ella più non trova, e per questo « importante subbietto dal quale dipende spesse volte la pace e la felicità delle famiglie» dà un consiglio alle donne ammogliate «Siate le amanti dei vostri mariti e fate che essi trovino nelle vostre carezze e ne’vostri baci quella voluttà che altre donne, in vostra vece, sapranno dar loro. La civetteria è santa e legittima quando la donna la esercita a cattivare lo sposo».[16]
Tra i personaggi del romanzo c’è Paolo Esposito, un trovatello, e come in tanti altri suoi romanzi, l’autore esegue una digressione su questa antica consuetudine napolitana «Il suo cognome diceva abbastanza della origina sua. Non ancora dalle nostre costumanze si era tolta quella barbarissima di apporre lo stesso cognome, o, per meglio dire, lo stesso marchio d’infamia a tutti gl’innocenti figli della colpa ricettati nella Santa Casa dell’ Annunziata».[17]
Profondamente religioso, anche in questo romanzo non mancano i riferimenti ecclesiastici «La dottrina cristiana stabilisce sette ordini di peccati capitali, cioè la Superbia, l’Avarizia, la Lussuria, l’Invidia, la Gola, l’Ira, l’Accidia. Le virtù opposte sono: l’Umiltà, la Liberalità, la Castità, la Carità, la Sobrietà, la Pazienza e il Fervore».[18]
Della sua amata città natia non manca mai di descriverne notizie e curiosità, come:
«Napoli è sempre briosa, ma specialmente in carnevale. Si direbbe una città, alla quale il dolore è ignota parola». [19] Ed ancora:
«Sotto la denominazione di Quadrilatero noi comprenderemo i quattro edifici che formano in Napoli i ridotti del vizio e del delitto, cioè: VICARIA, S. FRANCESCO, S. MARIA LA FEDE, S. MARIA AGNONE. Ecco il formidabile quadrilatero, in cui si perpetra o si espia il vizio e il delitto. Quivi è la sentina di quanto di più abbietto e morboso è nella nostra società»[20]
È probabile che la pizza sia stata concepita in quel periodo, ed all’inizio della sua concezione, era conosciuta presso il popolino; il padre di una protagonista del romanzo, la Mariantonia «era figliuola d’un manipolatore di quelle briose focacce che in Napoli si dicono pizze».[21]
Un altro personaggio del romanzo, l’ultimo ad entrare in scena, è un giovane russo ricco oltremodo, possiede un capitale di un miliardo di rubli. Mastriani lo definisce un gigante «che misurava quattro metri all’incirca», [22] ma secondo me trattasi di un errore tipografico! Quattro metri di altezza mi sembrano un po’troppi per un essere umano!
L’autore cerca di dare la spiegazione di come si possa arricchire «Come si fa ad accumulare un miliardo? Il denaro è prolifico come le piattole… Contate un miliardo se potete! Dalla nascita di nostro signore Gesù Cristo non sono passati ancora un miliardo di minuti».[23]
Anche in questo lavoro l’autore riproduce dei pensieri espressi in un altro suo libro, nei Misteri di Napoli, in questo caso, quando fa una digressione sulla FAME «Supplizio orribile che ha pochi eguali… questa sofferenza, tutta opera dell’uomo… sofferenza ignota a quei beati gaudenti, invitati al lauto banchetto della vita»[24] . Ed in questa digressione l’autore inserisce anche un verso della Divina Commedia di Dante, dopo aver annotato «Una pallidezza mortale copre le sembianze come vie più cresce lo spasimo della fame… ed io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso… Così parla il disgraziato conte Ugolino nel 33° canto dello Alighieri»[25] .
Un altro riferimento è quando descrive la morte cellecatoria «Il mostro quando si fu accertato che la piccina era bene avvinghiata in quelle ritorte, adagiolla sul letto e poscia sempre a mo’ di celia le andò vellicando con ambo le mani le piante dei piedi. Era questo un novello ed inaudito supplizio onde qualche anno addietro un marito avea spenta qui in Napoli la moglie con questa morte che si disse morte cellecatoria… la vittima ridea nello spasimo delle convulsioni»[26]
Decisamente contrario alla pena di morte, per qualsiasi reato venga commesso, in questo lavoro l’autore propone un’alternativa molto originale, ma secondo me malvagia «Avversari assoluti della Pena di Morte, la rigettiamo per ogni delitto; e pe’parricidi proponemmo LA STIA DI FERRO O LA GABBIA. Un parricida non appartiene alla razza umana; è belva noi dunque non faremo altro che segregarlo dalla umana famiglia e rinchiuderlo in quelle stie di ferro dove soglionsi chiudere le bestie feroci… l’altezza della gabbia sarà tale che il condannato non vi possa prendere a posizione orizzontale… egli sarà condannato alla giacitura orizzontale… il cibo gli verrà gittato dall’alto della gabbia… un cartello allogato su l’alto della Gabbia indicherà il nome del delinquente e il delitto…la pena della Gabbia è giusta, ragionevole, proporzionata, esemplare»[27]
Secondo il Guardiani i drammi descritti in questo lavoro sono due; invece ce ne aggiungerei un terzo, quello relativo alle vicende della famiglia corsa di Marco Boldini. La loro bellissima figlia Valentina, divenuta amante non solo del conte Ciriaco, ma anche di importanti personaggi di corte, conclude la sua irregolare vita, ammazzata da suo padre, che a sua volta si suicida, dopo aver vendicato il suo onore umiliato dalla mala condotta della figlia Valentina. E con queste due tragiche morti si conclude il romanzo.
ROSARIO MASTRIANI
[1] Francesco Mastriani, «I drammi di Napoli», Napoli, G. Regina 1878, vol.I, Prefazione, pag.XI.
[2] Ivi
[3] Ivi
[4] Ivi
[5] Francesco Mastriani, «Sotto altro cielo», Napoli, G. Salvati, 1892, Prefazione dell’Autore, pag.XIII.
[6] Francesco Mastriani, «I drammi di Napoli», Napoli, G. Regina 1878, vol.I, Prefazione, pag.V.
[7] Ivi
[8] Ibidem pag.VI
[9] Ibidem pag.VII
[10] Ibidem, vol.III, cap.I Un po’di anatomia, pag.25
[11] Ibidem, vol.II, cap.XV, Il Ministro, pag.68
[12] Ibidem, pag.73
[13] Ibidem, pag.74
[14] Ibidem, vol.V. cap.V. La creduta figlia, pag.46
[15] Ibidem, vol.V. cap.V. La creduta figlia, pag.48
[16] Ibidem, vol.I cap.IV Il dominò color di Rosa, pag.44
[17] Ibidem, vol.II cap.XVII La moglie, pag.88
[18] Ibidem, vol.II capXXXI La marchesa Castrioti, pp.32-33
[19] Ibidem, vol.III cap.XIX La fine di un dramma, pag.18
[20] Ivi, pag.32
[21] Ibidem, vol.III cap.II Mezzocannone, pag.40
[22] Ibidem, vol.V cap.IV Un ultimo atto, pag.73
[23] Ivi pag. 70
[24] Ibidem vol.III cap.V Paolina, pp.79-80
[25] Ivi, pag.83
[26] Ibidem vol.III cap.V Paolina, pp.73-74
[27] Ibidem vol.V cap.XV L’Animalità, pp.32.33